
RACCONTO
Adamo Bencivenga
LA ZOCCOLETTA
Roma, 1957. Anna, diciassette anni, scappa dal collegio delle suore in cerca di libertà, ma trova solo le strade sporche della sopravvivenza. Soprannominata "la zoccoletta", inizia a vendere se stessa in un albergo diurno, vicino alla Stazione Termini, finché un incontro cambierà per sempre il suo destino...

|
La guerra ha spazzato ogni cosa, non solo la vita, ma anche i sentimenti, gli affetti e la dignità, e la mia infanzia non è stata come quella dei bambini che vedi giocare nei cortili, sotto lo sguardo apprensivo delle madri. Sono nata a Roma, nel ’40 e mia madre mi ha chiamata Anna come sua sorella, mia zia, morta qualche mese prima che io nascessi. Ero piccola, ma ricordo bene il rombo degli aerei e il fragore dei bombardamenti su San Lorenzo, le corse nei rifugi e la fame che mordeva lo stomaco. Ero figlia unica e mia madre faceva la lavandaia per sfamarmi e si lamentava sempre per le mani gonfie, indolenzite dal freddo e dai detersivi che usava. Mio padre? Dicevano fosse un commerciante del nord, ma io non l’ho mai conosciuto e mia madre non me ne ha mai parlato, così quando a undici anni lei si ammalò e non si rialzò più dal letto rimasi completamente sola. Non avevo nessuno e nessun parente che volesse o potesse prendersi cura di me. Vissi per un po’ con la signora Gianna, una vicina di casa, ma poi nel giorno dei miei dodici anni, mi portarono in un collegio di suore Benedettine, tra il Tevere e Campo de’ Fiori, poco distante dal Conservatorio di San Clemente di Via delle Zoccolette, quello che un secolo prima aveva ospitato le trovatelle. ****** “Perché proprio me?” Mi chiedevo spesso, ma al collegio mi dicevano che dovevo considerarmi fortunata, perché ero sana, perché ero carina e non avevo deformità e che quindi se avessi fatto la brava sarei potuta rimanere lì, in quel collegio. Così accadde e nel tempo capii che cosa succedeva invece alle ragazze che soffrivano di qualche malattia o avevano qualche difetto. Come nell'Ottocento, non potendo lavorare e quindi sdebitarsi per quella permanenza, le suore le mandavano via e loro disperate continuavano a vagare nei dintorni, chiedendo l’elemosina o facendo piccoli servizi. Io lì, almeno, avevo un tetto, anche se quel tetto era freddo e bucato sopra quel convento fatto di regole ferree e tonache marroni che pizzicavano la pelle. Il collegio era grande a due livelli con uno stanzone enorme e umido che ospitava circa 50 ragazze. Le suore ci insegnavano le buone maniere e poi a leggere, a scrivere, a fare i lavori di casa e a pregare. Passavo le giornate a cucire il fustagno ruvido che serviva per i vestiti del popolo. “Lavora sodo, ragazzina.” Mi diceva suor Teresa, la meno anziana e severa delle monache. “Se non impari un mestiere, finirai in strada come tante altre.” Io annuivo, ma dentro di me sognavo altro: una casa, una famiglia, un po’ di calore, un posto dove essere chiamata per nome. Lì feci conoscenza con diverse ragazze, ma soprattutto con Clara, una ragazza di Roma più grande di me, che aveva avuto un passato simile al mio. La sera prima di dormire parlavamo poco e sognavamo tanto, di case accoglienti e ragazzi belli, ma poi quando venne mandata via perché aveva compiuto diciotto anni mi sentii ancora più sola. Ci parlai qualche mese dopo attraverso le inferiate del bagno al pianterreno, mi disse che per qualche settimana aveva fatto le pulizie da una signora, però poi quando la signora si era trasferita da suo figlio, lei per andare avanti, aveva iniziato a incontrare ragazzi. Il vestito che indossava, le scarpe, il trucco e il modo di fumare parlavano chiaro e non le chiesi altro, ma dentro di me iniziai ad invidiarla, non per quello che faceva, ma perché lei era in strada, libera di muoversi, ed io rinchiusa in quel piccolo cesso. Ci pensai per qualche giorno e così una settimana dopo, sempre con l’aiuto di Clara, che fece in modo di distrarre la suora guardiana, scappai dal collegio in cerca di un po’ di ossigeno. ****** Era il 1957, avevo diciassette anni e l’incoscienza dell’età. Respiravo quell’aria a pieni polmoni e mi sentivo felice, non pensando a come avrei vissuto. Camminammo a piedi per diversi chilometri finché seguendo le rotaie del tram arrivammo in una baracca di periferia vicino al Quadraro, che lei condivideva con altre due ragazze. Tutte e tre mi accolsero benevolmente ed io cercai di sdebitarmi rassettando la casa, lavando i piatti e rifacendo i letti, ma dopo una settimana Clara mi prese in disparte e mi disse che per rimanere lì con loro avrei dovuto fare certi servizi. Col terrore di dover tornare in collegio accettai e lei mi diede in prestito un suo vestito e delle scarpe col tacco alto di due misure più grandi. Ero piccola rispetto a loro sia d’età che di statura e loro mi dissero che, con quel vestito e il rossetto sulle labbra, avevo l’aria di una che era scappata dal collegio e allora ridendo mi soprannominarono “la zoccoletta”. La mattina dopo Clara mi accompagnò sul posto di lavoro, un albergo diurno con tanto di toilette pubblica chiamato “La casa del passeggero”, vicino alla Stazione Termini. Mentre andavamo mi chiese se fossi vergine e mi disse con aria materna: “Vedrai è un attimo, poi non ci penserai più.” Mi disse anche che non dovevo avere timore perché la bravura sarebbe arrivata con l’esperienza. Poi mi diede poche istruzioni su come farmi riconoscere e come apparire esperta raccomandandosi di non dire mai a nessuno la mia età. Entrammo nell’albergo e lei mi indicò in quale bagno avrei dovuto portare i clienti, poi se ne andò lasciandomi sola e, salutandomi con un mezzo sorriso, mi disse: “Metti ancora un po’ di rossetto, devi sembrare una vera zoccoletta, poi stasera vediamo quanto sei stata brava!”. Sola su quel marciapiede iniziai a camminare avanti e indietro chiedendomi come avrebbero fatto gli uomini a riconoscermi. Dopo circa un’ora, passeggiando sempre davanti all’albergo, si avvicinò un soldato di Palermo e lui fu il mio primo cliente. Come da istruzioni di Clara lo portai nel bagno più distante dall’uscita e lì in piedi mi alzai la gonna e lui consumò in fretta la sua voglia. Sentii un dolore lancinante, ma per non farmi accorgere che ero vergine soffrii in silenzio stringendo i pugni. Lui non si accorse di nulla e quando mi salutò mi disse che ero stata brava, ma a me quella cosa fece così schifo che vomitai nello stesso bagno. Mi appoggiai al muro, il dolore fisico tra le gambe era ancora lì, acuto, ma soprattutto era l’umiliazione a bruciarmi di più. Mi sentivo sporca come se fossi parte di quell’ambiente sudicio con il pavimento appiccicoso e l’odore forte di pipì. Ma mentre mi risciacquavo il viso con l’acqua fredda del lavandino di ferro arrugginito, guardandomi nello specchio qualcosa dentro di me si indurì. “Non tornerò in collegio!” Dissi a voce alta stringendo i denti. “Mai più.” Il pensiero delle tonache marroni, delle stanze umide, delle suore che mi chiamavano “ragazzina” con quel tono glaciale, mi dava una nausea più forte di quella che aveva appena provato. Là fuori, per quanto squallido fosse, c’era almeno una parvenza di libertà. Nel bagno puzzolente come nella baracca di periferia potevo essere Anna e non solo un’orfana senza nome. Allora uscii dal bagno con le gambe che ancora tremavano. Mi accorsi che non ero sola, ma c’erano altre ragazze che entravano e uscivano da quei bagni sottobraccio a soldati o uomini anziani. Ogni tanto un addetto ci scacciava fuori in malo modo, ma poi lentamente, ad una ad una, tornavamo dentro. L’aria era densa di fumo di sigarette, di pipì e disinfettante. Fuori la Stazione Termini era piena di viaggiatori, soldati, mendicanti e faccendieri, tutti avvolti nella miseria del 1957, un’Italia che cercava di rialzarsi dalle macerie della guerra, ma che per molti, come per me in quel momento, era ancora un luogo di sopravvivenza. Clara mi aveva detto di “farmi vedere” e di sorridere, ma timida com’ero non ci riuscivo. Mi limitavo a camminare su e giù per quel marciapiede e ogni tanto ad entrare cercando di intuire quale di quei passeggeri potesse essere un cliente. “Ce la farò!” Mi ripetevo, anche se ogni passo, ogni sorriso mi costava uno sforzo enorme. Non era solo la fame a spingermi, né il bisogno di un tetto sopra la testa. Era la rabbia, una rabbia sorda contro un mondo che mi aveva lasciata sola, che mi aveva costretta a scegliere tra un collegio e una strada sporca. Quella sera, dopo il soldato di Palermo, mi avvicinò un uomo di mezza età, un impiegato con un cappotto logoro e un cappello calato sugli occhi. Mi squadrò e poi mi chiese quanti anni avessi. Risposi prontamente 21, ma si vedeva a mille miglia che ero minorenne. Lui sorrise, mi accarezzò i capelli, poi si guardò intorno e alla fine mi disse di seguirlo. Era esperto, non ero sicuramente la prima e senza dire nulla mi portò nello stesso bagno, il più lontano dall’ingresso e dagli sguardi degli inservienti. Solo a quel punto, avvicinandosi e stringendomi le tette, mi disse che ero bella. Io chiusi gli occhi cercando di isolarmi e immaginando di essere altrove. Ma la realtà mi riportava lì, a quell’odore forte di urina e al freddo delle piastrelle contro la schiena. Non fu breve come col soldato di Palermo, lui mi incitava a muovermi e partecipare, obbedii e quando lui finì, mi lasciò qualche lira sgualcita in più e se ne andò senza guardarmi. Mi sistemai il vestito e questa volta non piansi. Mi sentivo come se stessi imparando a spegnere una parte di sé, a seppellire quel disgusto. Nei giorni successivi andai da sola con la gonna sempre più corta e strascinando i tacchi un po’ per le scarpe di due misure in più un po’per richiamare l’attenzione. I clienti erano tutti diversi, eppure tutti uguali: soldati di leva con pochi spiccioli, muratori con le mani sporche di calce, viaggiatori di passaggio che non si sarebbero mai ricordati del mio viso. Una volta, un uomo più gentile degli altri, un commerciante con un accento del sud, dopo aver consumato mi invitò a fare una passeggiata lungo il viale che portava a Piazza Esedra. Non so perché, ma mi sentii più grande, lui mi offrì una sigaretta, io la presi e la tenni tra le dita mentre lui parlava del suo paese, di un terreno con oltre cento ulivi e del mare all’orizzonte. Io non avevo mai visto il mare e lo ascoltai con attenzione. Poi mi comprò un gelato e ci sedemmo su una panchina. Lui mi sorrise più volte e chiese il mio nome dicendomi che avrebbe avuto piacere a incontrarmi ancora, ma non in quel posto. Ero imbarazzata, era la prima volta che un uomo grande mi dava tutta quella considerazione e per un momento dimenticai dove fossi, ma poi l’uomo se ne andò, non lo rividi più e io tornai a essere “la zoccoletta”, una ragazza senza storia, senza passato, ma con un bagno a poca distanza dove mi guadagnavo da vivere senza dignità. Eppure non riuscivo a comprendere il totale degrado anche perché la miseria di quel periodo era ovunque. Fuori dall’albergo, le strade erano piene di bambini scalzi che chiedevano l’elemosina, di donne che vendevano scarti di verdura ammaccata su cassette di legno, di uomini che caricavano carretti con rottami di ferro arrugginito per rivenderli. Ogni tanto, qualche poliziotto passava per una “ispezione”, annunciando la sua presenza da lontano in modo da non coglierci sul fatto. Determinata a non tornare indietro mi aggrappavo alla speranza che un giorno avrei trovato un modo per essere qualcosa di più della “zoccoletta” e che la mia vita sarebbe cambiata, ovvio non sapevo come e quando, ma la notte, nella baracca al Quadraro, mi svegliavo con il cuore che batteva forte, perseguitata da incubi in cui suor Teresa mi trascinava di nuovo al collegio. Non parlavo mai di quello che provavo, nemmeno con Clara, mi tenevo tutto dentro, ma intanto ogni lira che guadagnavo la mettevo da parte, nascosta sotto una tavola sconnessa del pavimento della baracca, sognando il giorno in cui avrei potuto affittare una stanza tutta mia. Ma quel sogno sembrava lontano, schiacciato dalla realtà e da ogni giornata passata a vendere ciò che restava di me. Mi ripetevo che in fin dei conti la libertà aveva un prezzo e quello era il mio prezzo! ****** Ma in quel 1957, in quell’angolo di Roma sporco e disperato, l’unica cosa che potevo fare era andare avanti, un passo alla volta, un cliente alla volta, con la caparbietà di chi non ha più nulla da perdere. Continuavo convinta che quella fosse l’unica strada per sopravvivere, ma un pomeriggio, qualcosa cambiò per sempre. Ero vicino alla stazione, dove le Terme di Diocleziano si sgretolavano sotto il peso del tempo, delle ortiche e dell’incuria. Due ragazzi, ben vestiti, con giacche di buon taglio si avvicinarono sorridenti. Non erano i soliti clienti, quelli con le mani callose e lo sguardo spento. Questi avevano un’aria di chi si sentiva padrone del mondo, con i capelli pettinati all’indietro pieni di brillantina e un modo di parlare che tradiva una certa educazione. Mi offrirono un cioccolato caldo in un chiosco lì vicino, e io, forse per stanchezza o per la vaga speranza di un momento di normalità, accettai. “Dai, siediti un attimo, che ti offriamo qualcosa di caldo.” Disse uno dei due, quello più alto, con un sorriso che sembrava gentile, ma aveva qualcosa di storto, come una lama nascosta. Si chiamava Giuseppe, o almeno così disse. L’altro, più basso e silenzioso, con occhi che sembravano perforarmi, non disse il suo nome. “Grazie.” Mormorai stringendo la tazza di cioccolato tra le mani. Loro mi facevano i complimenti dicendo che ero un bocconcino prelibato, ma poi, mentre il sole cominciava a calare e l’aria si faceva più fresca, Giuseppe si sporse verso di me. “Sai, Anna, sei una ragazza carina. Perché non vieni con noi? Solo un po’ di divertimento, niente di complicato.” Scossi la testa, il cuore che cominciava a battere più forte. “No, grazie. Non… non faccio certe cose. Non con due insieme.” Risposi, cercando di mantenere la voce ferma. Non avevo mai accettato situazioni del genere, e una vocina dentro di me mi diceva di scappare. Quello più basso, che fino a quel momento era stato zitto, rise, una risata secca e cattiva. “Oh, andiamo, non fare la preziosa. Lo sappiamo che fai la puttana. Non è che hai molta scelta, no?” Mi alzai di scatto: “Ho detto di no” Ribattei, e feci per andarmene. Ma non fui abbastanza veloce. Giuseppe mi afferrò per un braccio e urlò: “Dove credi di andare, eh?” A quel punto l’altro mi bloccò d’altro lato. Mi dissero di non gridare e mi trascinarono via dal chiosco, verso i ruderi delle Terme, dove l’ombra dei muri antichi inghiottiva ogni suono. Io gridai lo stesso, scalciai, cercai di liberarmi, ma loro erano più forti. Giuseppe mi colpì con uno schiaffo spaccandomi il labbro e l’altro mi spinse contro un muro. “Stai zitta e fai la brava!” Mi disse mentre mi teneva ferma. “Non vorrai mica che ti facciamo male sul serio, no?” Piansi con il terrore che mi chiudeva la gola. Nella mia mente, in quel momento di disperazione, vidi il volto di mia madre, un’immagine sfocata che non ricordavo quasi più. Lei mi disse: “Fai la brava, Anna. Pensa a sopravvivere.” Smisi di lottare, il mio corpo si arrese e loro abusarono di me, tra quei ruderi sporchi e silenziosi. Venti minuti che non dimenticherò mai! Quando finirono, mi lasciarono lì, nuda, tremante, con il sapore del sangue in bocca e il corpo che sembrava non appartenermi più. Come se non fosse successo niente Giuseppe si accese una sigaretta, e prima di andarsene mi guardò con un ghigno. “Non fare tante storie, ora puoi tornare al tuo mestiere che poi non è tanto diverso da quello che hai fatto ora.” Se ne andarono, lasciandomi sola tra le rovine. Mi tirai su a fatica con le gambe che tremavano. Mi rivestii come potei e lentamente tornai verso il Quadraro. Ogni passo un peso insopportabile, ma non era solo il dolore fisico, era qualcosa di più profondo, una crepa che si era aperta dentro di me. Per la prima volta, capii che non potevo continuare così. Non era libertà, quella. Era una prigione, e ogni cliente, ogni lira guadagnata, mi stava trascinando sempre più a fondo. Il ricordo di quell’uomo gentile, il commerciante del sud con il suo racconto degli ulivi e del mare, tornò a tormentarmi. Lui mi aveva guardata come se fossi una persona, non un oggetto. E ora, dopo quello che era successo, quel ricordo era l’unica cosa che mi dava la forza di pensare a un futuro diverso. Non sapevo come, non sapevo quando, ma giurai a me stessa che non sarei più tornata in quel bagno lurido, in quel viale, in quel mondo che mi stava uccidendo. Avrei trovato un modo per essere qualcosa di più, per essere Anna, non “la zoccoletta”. Anche se significava ricominciare da zero, anche se significava affrontare la fame e la paura, non avrei più venduto me stessa. Quando tornai nella baracca misi come al solito parte dei soldi guadagnati sul tavolo e poi senza dire nulla, indossai i miei vestiti sporchi del collegio e abbandonai quella casa intenzionata a fare ritorno dalle suore, ma fu proprio quella sera che cambiò la mia vita. ****** Timorosa della reazione delle suore, esitai, incerta sul da farsi. Non sapevo se mi avrebbero riaccolta o quali punizioni mi attendessero per la mia fuga. Decisi di prendere tempo, vagando senza meta per le strade di Roma, con l’idea di trascorrere almeno quella notte fuori, sperando che l’aria fresca e il silenzio della città mi aiutassero a schiarirmi le idee. Camminavo con il cuore pesante, i passi incerti che risuonavano sui sampietrini umidi, quando, nei pressi della Fontana delle Tartarughe, nel cuore del Ghetto, un uomo anziano mi notò. Era ben vestito, con un cappotto scuro di buona fattura e un cappello di feltro leggermente inclinato. Portava i capelli brizzolati e il suo volto, segnato dal tempo, aveva un’espressione gentile, quasi paterna. Si avvicinò con passo lento, come per non spaventarmi, e i suoi occhi, di un castano caldo, sembravano scrutarmi con una curiosità benevola. “Hai fame, ragazza?” Mi chiese con una voce morbida, leggermente roca, che tradiva un accento romano appena accennato. Intimidita, abbassai lo sguardo, stringendo il bordo del mio scialle logoro. Non riuscii a rispondere subito, ma il mio stomaco, traditore, emise un lieve brontolio che fece sorridere l’uomo. Annuii timidamente, e lui, senza insistere o fare domande, mi fece cenno di seguirlo. “Vieni, conosco un posto qui vicino.” Disse, indicando una stradina laterale. Camminammo in silenzio per qualche metro, io un passo dietro di lui, ancora incerta se fidarmi. Arrivammo davanti a un’osteria, una di quelle taverne romane con le tende a quadretti rossi e bianchi e l’insegna di legno che cigolava leggermente al vento. L’interno era caldo e rumoroso, con tavoli di legno massiccio coperti da tovaglie a scacchi, illuminati da candele infilate in bottiglie di vino vuote. L’odore acre di vino, misto a quello di unto e di carne arrostita, mi avvolse, facendomi quasi girare la testa per la fame. L’uomo si tolse il cappello e lo appoggiò su una sedia, poi mi indicò un tavolo in un angolo, lontano dal chiacchiericcio degli altri avventori. “Siediti, stai tranquilla.” Disse con un sorriso che sembrava voler dissipare ogni mia paura, poi chiamò il padrone dell’osteria, un uomo robusto con un grembiule macchiato, e ordinò per me un piatto di spaghetti. “Per la ragazza.” Disse, guardandomi con un cenno di complicità. “E un bicchiere di rosso per me, ma per lei solo acqua…” Mentre aspettavamo il cibo, parlò del Ghetto, della fontana lì vicino con le sue tartarughe che, diceva, “sembrano sempre sul punto di andare via, ma non si muovono mai.” La sua voce aveva un ritmo pacato, come se mi raccontasse una favola, e per un momento dimenticai la mia angoscia. Quando il cibo arrivò, mi incoraggiò a mangiare con un gesto della mano, come un nonno che insiste con il nipote. “Forza, che la fame non aspetta.” Disse, e io, dopo un primo boccone, mi lasciai andare al calore del piatto fumante, sentendo il conforto di quel gesto semplice, ma profondamente umano. Lui mi osservava con un misto di curiosità e dolcezza, ogni tanto sorseggiava il suo vino. Alla fine mi chiese: “Come ti chiami?” “Anna.” Risposi, con la bocca piena. “E come sei finita qui, Anna?” Gli raccontai tutto, o quasi. Della guerra, di mia madre, della fuga dal collegio e la paura di dover rientrare. Non dissi nulla di Clara e di cosa facevo e cosa mi era successo qualche ora prima. Lui mi ascoltava con gli occhi pieni di qualcosa che non capivo. ****** Si chiamava Mario, insegnava al liceo in zona e viveva poco lontano, sempre nel Ghetto. Quando finii di mangiare, mi disse: “Non vuoi tornare in collegio stasera, vero?” Annuii con la testa e lui disse: “Vieni a casa mia, solo per questa notte…” Non dissi nulla, ma speravo ardentemente che il destino si fosse girato a mio favore. Quell’uomo era troppo gentile per aspettarmi qualcosa di brutto e poi pensai che qualunque cosa fosse accaduta non sarei andata più in fondo di quello che mi era successo. Comunque, facemmo poca strada a piedi e prima di arrivare a casa, lui estrasse dalla tasca il suo pettinino e mi sistemò i capelli, poi mi confidò che era padre di un ragazzo di ventuno anni, ma che avrebbe sempre voluto avere una figlia femmina. L’appartamento al primo piano era grande, caldo, con la radio accesa. Mi sembrò un sogno. La tavola era apparecchiata, il profumo di minestra riempiva l’aria. Ma la signora Sandra, sua moglie, non fu affatto felice di vedermi. “Chi è questa?” Sbottò, squadrandomi come fossi un gatto randagio. “Solo per stanotte, Sandra…” Disse Mario, calmo. “Domani troveremo una soluzione.” Prima di sedersi a tavola per la cena, Mario mi preparò la stanza degli ospiti sistemandomi il letto. Quella notte dormii in una stanza tutta da sola, non mi pareva vero… abituata com’ero nel dormitorio freddo e pieno di spifferi del collegio con le altre ragazze che urlavano fino a tardi. La mattina dopo mi alzai presto sempre con l’angoscia di dover tornare in collegio, ma il professor Mario non mi mandò via. Mentre facevo colazione mi disse: “Abbiamo bisogno di una mano in casa, Anna, però tu devi darti da fare...” Sua moglie sbuffò, ma alla fine accettò. La loro casa era grande, con i pavimenti di marmo e tende pesanti alle finestre. A me sembrava un palazzo di ricchi. La mattina stessa il professore mi portò in un grande magazzino vicino Piazza Vittorio e mi comprò dei vestiti nuovi, semplici, ma puliti. Ero felice, lui mi trattava con una gentilezza che non conoscevo, quasi come fossi sua figlia. “Anna, sei una ragazza sveglia.” Mi diceva. “Devi studiare, costruirti un futuro.” Le faccende domestiche non erano faticose e cercavo di sbrigarle durante la mattina anche perché nel pomeriggio il professor Mario dopo qualche giorno iniziò a darmi lezioni private, aiutandomi a preparare gli esami da privatista di terza media. La sera nel letto pregavo ringraziando il Signore per quell’opportunità anche se sapevo che non sarei potuta restare in quella casa per sempre. “Quando compirai diciotto anni, dovrai trovarti un ragazzo che ti sposi, Anna…” Mi disse il professore una volta, con un tono serio, ma buono. “Questa non è casa tua.” Fu lì che sentii un enorme distacco e ci rimasi male, ma dentro di me sapevo che aveva ragione. Davide, il figlio di Mario, era un tipo silenzioso e riservato, aveva i capelli mossi e un sorriso che mi faceva tremare le gambe. Era bello, gentile, colto, sempre con un libro in mano. Quando era in casa passava le ore chiuso nella sua stanza a studiare e nelle poche volte che mi rivolgeva la parola dimostrava una delicatezza infinita. Insomma, non mi ci volle molto ad innamorarmi di lui, ma lui non mi notava, un po’ per il suo carattere, un po’ perché aveva quattro anni più di me e un po’ perché era fidanzato con Laura, una ragazza bionda con i capelli lunghi e lisci, ricca e sempre elegante, che sembrava uscita da un film a colori. Io, con i miei vestitini da poco, i capelli neri, mossi e disordinati e le mani screpolate dal lavoro, non potevo di certo competere con lei. La domenica pomeriggio uscivo con Clara che nel frattempo aveva smesso di fare la vita ed usciva con un uomo ricco, ma sposato. Quando ci riavvicinammo mi disse: “Avevi ragione tu ed io mi sento in colpa.” Poi ridendo aggiunse: “I soldi non sono tutto, non ti rendono felici, ma io continuo a pensare che ti fanno vivere bene.” Tutte e due con la domenica libera andavamo di solito al cinema o ad una sala da ballo vicino Via di Torre Argentina. Lì c’era un’orchestrina composta da cinque o sei elementi e suonava pezzi dai ritmi americani tipo swing e boogie-woogie. Non mancavano i lenti, come i boleri o i valzer, che facevano avvicinare le coppie in pista. Un pomeriggio Clara arrivò con una busta enorme con dentro una gonna rossa corta a pieghe, un paio di calze di seta nere, delle scarpe coi tacchi alti, un po’ consumate, e un rossetto già usato. Mi trascinò nel bagno del locale: “Fatti bella, Anna.” Mi disse, seria. “Se vuoi qualcosa, devi prendertelo. Se vuoi un futuro devi trovare un uomo che ti sposi, ma prima devi sbalordirlo.” A casa, però, ero solo la sguattera. Pulivo, lavavo, cucinavo, anche se dentro di me ero convinta che un giorno avrei avuto un futuro migliore, non sognavo la ricchezza come Clara, ma una casa mia e un uomo tutto per me. Ma, quando qualche ragazzo si avvicinava e mi chiedeva di ballare, mi venivano ancora in mente il bagno pubblico e quei due balordi. L’amore lo vedevo come qualcosa di oscuro, sporco, violento e peccaminoso, simile ad una toilette di giorno che puzzava di pipì. E poi non ero vergine, questo lo sapevo, ma non volevo pensarci. ****** Eravamo ancora nel 1957 e alla fine di quell’anno conobbi Marco, il commesso della pasticceria proprio di fronte casa mia. Era un ragazzo di venticinque anni, con i capelli castani leggermente mossi, occhi grandi e un sorriso aperto e sincero. Ogni mattina, mentre passavo davanti alla vetrina piena di cornetti caldi e torte glassate, lui mi salutava con un cenno, e col tempo quel saluto si trasformò in chiacchiere brevi e sorrisi complici. Iniziò a corteggiarmi con una dolcezza semplice, senza pretese: un caffè, una battuta sul tempo grigio di Roma, un complimento timido. Non sentivo per lui lo stesso trasporto che provavo per Davide, ma mi piaceva stare insieme a lui. Era serio, gentile, di buona famiglia, anche se non aveva molto da offrire se non la sua onestà e un lavoro umile. Pensai che, forse, un ragazzo così poteva essere la stabilità di cui avevo bisogno, insomma qualcuno che mi avrebbe tolta da quella precarietà di domestica senza casa e famiglia. Una mattina, mentre tornavo dal mercato con una busta piena di frutta e verdura, come al solito passai davanti alla pasticceria, ma quella volta, indossando la mia gonna rossa a pieghe che mi aveva regalato Clara. Certo sì, lo feci con un pizzico di civetteria e la voglia di farmi guardare. Marco appena mi vide uscì di corsa dal negozio con il grembiule ancora legato in vita e, pulendosi le mani infarinate su uno strofinaccio, mi fermò sorridendomi. “Anna, aspetta!” Si avvicino con un’aria un po’ sorpresa e mi disse. “Ti sta proprio bene questa gonna, sai? Sembri… diversa… più grande.” Arrossii, abbassando lo sguardo. Lui notando il mio imbarazzo aggiunse: “Dico sul serio, sei bellissima! Vieni, ti offro un cannolo. Non puoi dire di no a un cannolo siciliano fatto come si deve.” Entrai, e mentre mi porgeva il dolce su un piattino, continuò a chiacchierare, raccontandomi di come sua nonna gli avesse insegnato a fare la crema di ricotta perfetta. Era facile parlare con lui, e quella semplicità mi conquistò. Così iniziammo a uscire insieme. Mi portava al cinema di quartiere, dove guardavamo commedie romantiche o vecchi film d’avventura, e ridevamo per le stesse battute. Stavo bene e mi faceva sentire spensierata. Un pomeriggio, dopo qualche settimana che ci frequentavamo, mi regalò una fedina d’argento: “Non è niente di che.” Disse, grattandosi la nuca. “Ma… ci tengo a te, Anna. Voglio che tra noi nasca qualcosa di serio.” Lo guardai, sorpresa. “Marco, sei sicuro? Cioè… ci conosciamo da poco…” Lui si fece serio: “Sì, sono sicuro! E poi, voglio presentarti ai miei. Mia sorella non vede l’ora di conoscerti. Le ho già detto che sei una ragazza speciale.” Quella sera, davanti alla Fontana di Trevi illuminata, mi baciò con una dolcezza che mi fece quasi credere che fosse davvero lui quello giusto. “Anna sei la ragazza che voglio accanto a me. Promettimi che ci sarai.” Non risposi subito, ma annuii, lasciando che il suono dell’acqua della fontana riempisse il silenzio. Dentro di me, però, c’era un’ombra anzi un neo che non riuscivo a scacciare. Infatti, una domenica pomeriggio, invece della nostra solita passeggiata lungo il Tevere, Marco insistette per portarmi a casa sua. I suoi genitori erano fuori a pranzo da uno zio. Mi fece vedere la sua stanza, con un letto singolo, una scrivania piena di libri di scuola ormai impolverati e una foto di lui da bambino con sua sorella. Ci sedemmo sul letto, e tra una risata e un racconto, iniziammo a baciarci. I suoi baci erano dolci, ma c’era una passione nuova, più intensa, che mi sorprese. Mi lasciai andare, forse più di quanto avrei voluto e dovuto, e in quel momento di intimità, con le tende che filtravano la luce del pomeriggio, facemmo l’amore. Fu un gesto tenero, quasi goffo, ma Marco fu attento, premuroso, chiedendomi ogni volta se avessi voglia di continuare. Alla fine successe e quando finimmo, però, qualcosa cambiò. Mentre eravamo ancora sdraiati su quel lettino, lui si alzò di scatto, con un’espressione che non gli avevo mai visto prima. Si passò una mano tra i capelli, il volto teso. “Anna. Ti devo chiedere una cosa, ma tu promettimi di dirmi la verità!” Disse, con un tono che mi fece gelare il sangue. “Con chi sei stata prima di me?” Rimasi impietrita, il cuore che batteva forte. La sua voce non era più dolce, ma tagliente, quasi accusatoria. “Cosa… cosa vuoi dire?” Balbettai, stringendo il lenzuolo contro il petto. “Non sei vergine!” Disse, guardandomi dritto negli occhi. “Me lo dovevi dire. Con chi sei stata, Anna? Dimmi la verità!” Quel tono mi ferì come una lama. Non era solo la domanda, ma il modo in cui l’aveva detto, come se lo avessi ingannato o fossi improvvisamente diventata un’estranea, come se mi stesse giudicando. Non risposi. Non riuscivo a parlare, non volevo giustificarmi. Mi alzai, mi rivestii in fretta, con le mani che tremavano, e uscii da casa sua senza dire una parola. Camminai fino a casa con le lacrime che mi rigavano il viso. Il giorno dopo, Marco mi aspettò sotto il portone. “Anna, non possiamo andare avanti. Mi dispiace, ma non è più la stessa cosa.” Sentii una stretta al petto. Ero delusa, sì, ma non devastata. Forse perché in fondo non ci avevo mai creduto, forse sapevo che sarebbe finita così o forse perché il mio cuore era già di Davide. Ripresi la mia vita con un senso di leggerezza, sollevata per aver scampato quello che, col senno di poi, mi sembrava un pericolo. Le parole dure di Marco, il suo sguardo accusatorio, mi avevano ferita, ma allo stesso tempo mi avevano aperto gli occhi. Seduta sul lettino della mia stanza, con una tazza di tè ormai freddo tra le mani, riflettevo su quanto fosse accaduto. In fin dei conti, mi dicevo, un ragazzo che considera la verginità di una donna così importante, al punto da giudicarmi e lasciarmi senza nemmeno ascoltare le mie ragioni, non avrebbe mai potuto essere il mio uomo, quello con cui condividere una vita intera. Non era solo il suo rifiuto a pesarmi, ma il modo in cui aveva ridotto tutto ciò che ero a un dettaglio che per me non definiva chi fossi. Marco si era costruito un’immagine di me che non corrispondeva alla realtà: “Non è la stessa cosa.” Aveva detto e quelle parole mi risuonavano in testa come un’accusa. Meritavo qualcuno che mi vedesse per intero, che accettasse ogni parte di me, anche le cicatrici di un passato che non potevo cambiare. Mentre guardavo fuori dalla finestra, sentii una nuova determinazione crescere dentro di me. Non avrei permesso al giudizio di Marco di definirmi. La mia vita apparteneva a me, e il mio cuore, nonostante il dolore e le delusioni, batteva ancora per Davide, l’unico che con la sua sensibilità avrebbe potuto comprendermi davvero. Era diventato il mio chiodo fisso, il metro con cui giudicavo il mondo e facevo paragoni con chiunque altro. Eppure, nonostante vivessimo nella stessa casa, non si era mai presentata la minima possibilità per rivelargli ciò che provavo per lui. |
CONTINUA LA LETTURA
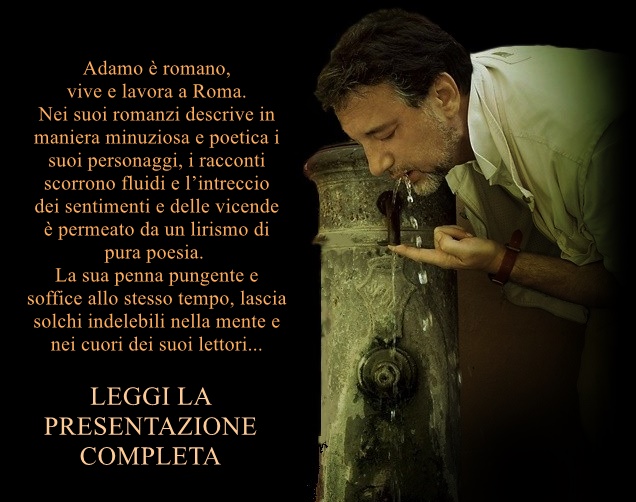
Questo racconto è opera di pura fantasia.
Nomi, personaggi e luoghi sono frutto
dell’immaginazione dell’autore e non sono da
considerarsi reali. Qualsiasi somiglianza con
fatti, scenari e persone è del tutto casuale.
IMMAGINE GENERATA DA IA
© All rights reserved Adamo Bencivenga
LEGGI GLI ALTRI RACCONTI
© Tutti i diritti riservati
Il presente racconto è tutelato dai diritti d'autore.
L'utilizzo è limitato ad un ambito esclusivamente personale.
Ne è vietata la riproduzione, in qualsiasi forma, senza il consenso dell'autore

Tutte le immagini pubblicate sono di proprietà dei rispettivi autori. Qualora l'autore ritenesse improprio l'uso, lo comunichi e l'immagine in questione verrà ritirata immediatamente. (All images and materials are copyright protected and are the property of their respective authors.and are the property of their respective authors.If the author deems improper use, they will be deleted from our site upon notification.) Scrivi a liberaeva@libero.it
COOKIE POLICY
TORNA SU (TOP)
LiberaEva Magazine Tutti i diritti Riservati Contatti
