
RACCONTO
Adamo Bencivenga
L'OMBRA NELLA NOTTE
Tra il peso della sopravvivenza e la ricerca di un frammento di dignità, Yara incarna il dramma universale di chi vive ai margini di una società distrutta dalla guerra. In un mondo di macerie e ipocrisia la sua vita notturna è un grido di resistenza contro un’esistenza che la riduce a un’ombra

|
Passeggio per le strade di Kalatà, la mia città, qui tutto è un velo di polvere e paura. Da dopo la guerra nulla è rimasto uguale. Dicono che sia stata la liberazione, ma io sinceramente non vedo nulla di positivo. La chiamo Kalatà, ma è un nome che ho inventato. Non importa dove sia o come si chiami davvero, perché tutte le città del mondo, dopo una guerra, sono uguali. Puzzano di morte e tragedia, di cenere e rimpianti. Le strade, i volti, le case distrutte… tutto si mescola in un’unica ferita che non smette di sanguinare. Le sue strade, coperte di polvere e macerie, raccontano una storia universale: quella di case sventrate, mercati silenziosi e vite distrutte. È un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, intrappolato tra il fragore delle bombe passate e il peso di un presente senza speranza. Kalatà è ovunque ci sia stato conflitto, ovunque la paura e il caos abbiano preso il posto dell’ordine, per quanto fragile fosse. Certo non è che prima si stava bene, perché Kalatà è stata sempre una città contesa tra il governo centrale e le forze rivoluzionarie, poi però sono arrivate le bombe dei russi, degli inglesi e immancabilmente degli americani. Prima della guerra la vita aveva un ordine, anche se duro, c’era paura, sì, ma era una paura prevedibile. Sapevi chi evitare, cosa non dire. Al tempo sognavo di studiare, magari di diventare insegnante o una parrucchiera. Ma la guerra ha cambiato tutto. Quando le bombe hanno smesso di cadere e i carri armati hanno occupato le strade, la città si è trasformata. Non c’era più un governo, non c’era più un sistema, un punto di riferimento e nemmeno una tubatura d’acqua funzionante. Solo polvere e caos. Le strade di Kalatà sono diventate un labirinto di checkpoint e milizie e noi donne siamo finite in mezzo, oppresse e subalterne come prima. Le famiglie si sono spezzate, gli uomini sono partiti per combattere o sono morti, e molte di noi sono rimaste sole, senza niente. Le poche donne che lavoravano sono state licenziate ed è stato allora che ho dovuto prendere la mia decisione, perché non c’era altro modo per sopravvivere. La società è cambiata, e io l’ho vista mano mano nei dettagli, nei piccoli gesti. Prima si usciva per un caffè, una passeggiata con le amiche, ma ora, le strade sono piene di ombre come me, ragazze che vendono quello che resta di loro stesse. Non è solo la povertà, è la libertà malata che è arrivata con gli invasori. Dicono che ci abbiano liberate, ma per molte di noi è una libertà che sa di catene. Gli uomini locali hanno iniziato a guardarci diversamente, senza rispetto. Non più come sorelle o figlie, ma come prede. I soldati stranieri, con i loro soldi facili, hanno portato un mercato nuovo, e noi siamo diventate come la merce esposta nei mercati. Io, che cammino di notte per le strade di Kalatà, vedo gli sguardi delle altre donne, quelle che ancora hanno una casa, una famiglia. Mi giudicano, ma non sanno che anche loro sono a un passo dal mio destino. Basta una bomba, un marito morto o una casa distrutta. Del resto siamo sempre le prime a pagare. Ci dicono di non parlare, di non esistere. Eppure, allo stesso tempo, ci sono uomini che vengono da noi, di nascosto, e poi di giorno fanno finta che non esistiamo. È un’ipocrisia che mi fa ribollire il sangue. Non so se questo sia il futuro immaginato per noi. Dicono che stiamo costruendo un futuro, ma io vedo solo macerie. Le scuole sono chiuse, gli ospedali sono un disastro, e le ragazze come me non hanno più sogni. Qui a Kalatà, il cambiamento è un lusso che non possiamo permetterci. Oh che sciocca non mi sono ancora presentata! Mi chiamo Yara, ho vent’anni, ho gli occhi verdi, un neo poco sotto l’occhio sinistro e due labbra grandi e rosse che sono l’unica mia fonte di guadagno. I miei sono morti per una bomba assassina durante la guerra ed io vivo con le mie sorelle. I giornali e le televisioni hanno smesso di parlare di noi, perché per loro la guerra è solo bombe e morte, ma la vera morte è ora per chi è sopravvissuto. Forse un giorno qualcuno ricorderà che oltre ai morti c’eravamo anche noi, noi sopravvissuti, schiacciati tra le macerie di una guerra che non abbiamo scelto. Ed io senza più padre e madre sono dovuta crescere in fretta. Di notte le strade si svuotano e tra i vicoli illuminati pulsa un mondo che nessuno vuole nominare e quello è il mio mondo. Seduta sulle rovine di un palazzo sventrato guardo la città che si spegne. È mezzanotte, e l’unico suono che mi accompagna è il ronzio intermittente di un generatore in lontananza. La luce gialla di un lampione mezzo rotto illumina a stento il mio angolo di mondo. Indosso calze a rete dorate e rosse, che scintillano ai riflessi della luna. I tacchi vertiginosi, neri e lucidi, mi sollevano da terra, ma non dal peso di questa vita. Il vestito sintetico che brilla come seta vera, aderisce al corpo con una scollatura che lascia poco all’immaginazione. Sotto, la lingerie è un segreto che porto con me: un reggiseno di pizzo nero ricamato e un perizoma coordinato, comprato a borsa nera da un uomo che non fa domande. Ogni pezzo è un’armatura che mi costruisco, un’illusione di potere in un mondo che me lo strappa via. Prima di uscire, il rituale è sempre lo stesso, mi vesto con cura come se stessi dipingendo un quadro. Nella stanza che divido con le mie sorelle, mi preparo in un angolo, dietro una tenda logora che funge da separé. Mi siedo su una sedia di plastica, davanti a uno specchio incrinato che apparteneva a mia madre. Il beauty-case è un caos di trucchi rubati o comprati a poco prezzo: il rossetto rosso fuoco che spalmo con cura seguendo il contorno delle labbra con un pennellino consumato; il kohl, nero e denso che stendo con le dita, sfumandolo fino a far sembrare i miei occhi più grandi. Ogni gesto è un atto di trasformazione, un passaggio da chi sono a cosa devo apparire. La lingerie è nascosta sotto un lenzuolo, lontano dagli occhi delle mie sorelle. La scelgo con cura: il pizzo nero è un lusso che mi concedo, un frammento di bellezza in un mondo che la nega. Il reggiseno ha le spalline sottili e il perizoma, con il suo bordo di pizzo, è così fragile che sembra possa strapparsi al primo movimento. Faccio tutto in silenzio e rapidamente come se stessi commettendo un crimine. E forse lo è, in un certo senso. Ogni volta che mi vesto così, sento il peso di una doppia vita: la ragazza immacolata di giorno e questa creatura notturna, che esiste solo sotto la luce del neon. Sono gesti rapidi e meccanici e non c’è più poesia, ma solo abitudine e l’ostinazione di piacere per qualche dollaro o rublo in più. Le mie sorelle sanno cosa faccio, che faccio la puttana, anche se non lo diranno mai ad alta voce. Quella parola ci fa paura e schifo. Quando torno a casa all’alba, con il trucco sbavato e i tacchi nascosti in una borsa di plastica, i loro occhi mi evitano facendo finta di dormire. Non c’è giudizio nei loro sguardi, solo una rassegnazione che ci accomuna. Siamo orfane e la sopravvivenza ha un prezzo che paghiamo in modi diversi. La più grande, lava i panni per le famiglie ricche di Kalatà; la più piccola vende agli nei vicoli. Io porto a casa i soldi che tengono insieme i pezzi della nostra vita. La vergogna mi brucia dentro quando mi siedo con loro a colazione, con il sapore del rossetto ancora in bocca e l’odore di profumo scadente che mi segue come un’ombra. Mi guardo allo specchio e mi vedo bella, non per i miei occhi, ma per gli sguardi dei maschi che tra poco mi divoreranno. Per lavorare ho dovuto accettare di vestirmi in questo modo perché la concorrenza anche se non si vede è molto agguerrita. La lingerie la compro in un sexy shop, per così dire, ma in realtà è un negozio che di giorno in vetrina espone detersivi e roba per la casa, ma quando il sole tramonta, il titolare, un uomo basso con i baffi ingrigiti, tira fuori la merce vera. La porta si chiude a chiave, e il negozio si trasforma. Dietro un bancone di legno, c’è una tenda di perline che nasconde una stanza sul retro. È lì che tiene la roba. Non sarebbe illegale venderla, ma lui sente il peso della vergogna come se stesse spacciando droga. Quando vado a comprare, è sempre lo stesso copione. Lui non fa domande, ma a volte allunga le mani ed io accetto perché mi fa lo sconto. Poi mi passa un sacchetto nero e io pago. Non scelgo quasi mai, tanto non è per me quella roba. L’ultima volta, mi ha venduto un completino di pizzo nero, quello che indosso stasera. “Buona qualità, non come quella cinese, e poi su di te farà un effetto incantevole…” Ha detto. Ho controllato la merce sotto la luce fioca: il pizzo era ruvido, ma aveva un’aria di eleganza che mi ha fatto sentire, per un istante, meno sola. Ho pagato senza contrattare, perché il tempo è denaro, e il mio tempo scorre troppo in fretta. Ora seduta su queste rovine, con il vento che mi porta l’odore di fumo e metallo, mi chiedo se questa sia davvero la mia vita. Il rossetto rosso fuoco, il kohl che mi brucia gli occhi, le calze a rete che mi graffiano la pelle: sono la mia armatura, ma anche la mia prigione. Kalatà dorme, ma io sono sveglia, un’ombra tra le ombre, in attesa di un cliente, di un’alba, di qualcosa che non so nemmeno nominare. Questo è il grande buco nero ed io sono il suo segreto. Quando le serrande dei negozi si abbassano, la vita rispettabile finisce e inizia un’altra realtà. Un mondo di corpi, di desideri nascosti, di perversioni sussurrate. Vengono da me tutti: i mercanti, gli uomini d’affari, i soldati inglesi e italiani rimasti qui come presidio. Quando sono fortunata ne ricevevo anche tre in una notte. Parlano poco, sono sempre ubriachi, ma pagano bene. Lavoro in due tre posti diversi che alterno per non dare nell’occhio, ma il mio preferito è un vicolo illuminato solo dal bagliore intermittente di un lampione che sfrigola come se fosse sul punto di spegnersi. Qui mi sento più sicura e appoggiata al muro, tra le rovine di un palazzo bombardato mostro la mia merce aggraziata dalle calze a rete dorate e dal vestito aderente che riflette alla luce le mie forme. Non sono bella, insomma non sono da copertina di rivista, ma so che piaccio, almeno come sfogo, almeno per qualche minuto! Il rossetto rosso fuoco è ancora perfetto, anche se so che non durerà a lungo. Nel silenzio della notte si sentono passi incerti, il suono di suole che strisciano sul selciato polveroso. È il rumore del cliente, che si avvicina di solito titubante, di solito un uomo qualunque, uno dei tanti. Un cappello calato sugli occhi, come se volesse nascondersi dalla moglie o dalle figlie. Si ferma a qualche metro, le mani nelle tasche. Lo guardo, senza sorridere, senza invitare. Anche in questo mestiere ci sono delle regole da rispettare tra uomo e donna. So che deve essere lui a fare il primo passo. I suoi occhi si muovono rapidi, dal mio viso al vestito, alle gambe, per poi ricominciare chiedendosi se sono adatta alle sue voglie. “Quanto?” Chiede infine, con la voce bassa come se temesse di essere ascoltato. La parola esce pesante, carica di desiderio e disgusto. Come fossi una dose di crack che odia, ma non ne può fare a meno. A quel punto so cosa devo fare, mi stacco dal muro per farmi ammirare e rispondo: “Dipende da cosa vuoi.” Lui esita, si passa una mano sul mento con la barba corta che gratta contro le dita. “Solo… quello che fai di solito.” Risponde senza guardarmi. So cosa significa: vuole il minimo, l’atto rapido, senza complicazioni, senza parole. È sempre così con quelli come lui, quelli che vengono di nascosto, che sfogano la loro voglia e poi tornano alle loro vite come se nulla fosse. “Cinquecento.” Dico senza guardarlo. E come tutti gli altri fa una smorfia, come se si aspettasse qualcosa di meno, ma non discute, vuole solo fare in fretta. A quel punto tira fuori una manciata di banconote sgualcite dalla tasca contandole sotto la luce del lampione. “Qui?” Chiede, guardandosi intorno, come se si aspettasse di vedere una pattuglia sbucare dal nulla. Indico un angolo più scuro, dietro un cumulo di macerie dove il muro forma una nicchia nascosta. “Andiamo.” Dico e quelle rovine ci inghiottono, complici e indifferenti. Lui mi segue, i passi più decisi ora, spinto da un’urgenza che supera la sua titubanza mentre io so già cosa viene dopo: un incontro rapido che dura quanto un respiro. Non gli chiederò il nome, né lui il mio. È solo un momento, una fusione di pelle, un frammento di sopravvivenza e non c’è dolcezza, solo un’urgenza cruda, una fame che non ha nulla a che vedere con l’amore. Lui apre la cerniera dei pantaloni ed io mi inginocchio e lo preparo, quando sento che è al culmine del desiderio mi alzo e mi appoggio al muro, il freddo del cemento mi morde la schiena. Lui, un estraneo senza nome, con le mani ruvide e gli occhi che non mi guardano, si avvicina. Non ci parliamo, non ce n’è bisogno. Le parole sono un lusso che nessuno dei due può permettersi. I nostri corpi si uniscono che è più lotta che carezza, un groviglio di membra che si muovono con rabbia, come se ogni gesto fosse un grido contro la guerra che ha distrutto le nostre vite, contro la fame che morde lo stomaco, contro le rovine che inghiottono i sogni. La sua mano mi stringe i fianchi con troppa forza, mi lascia segni che domani coprirò con un po’ di trucco. Ogni suo movimento è rapido, quasi violento, non cerca intimità, ma solo sfogo. È un effimero atto liberatorio, un istante in cui la polvere di Kalatà, il peso della miseria, la paura delle bombe si dissolvono in un’esplosione di sensi. Nonostante sia dentro di me lo sento distante perché qui non c’è tempo per la tenerezza, né spazio per i sogni. Il suo respiro è un grugnito soffocato, e il vicolo tace, complice e indifferente. Per un attimo, in quel groviglio di corpi, la guerra si ferma. La fame tace. Le rovine non esistono. Ma è un attimo, fugace come il battito d’ali di una falena. Lui spinge senza grazia, come un animale, perché non teme il mio giudizio, perché sa che tra pochi secondi sarà solo un’ombra nella notte. Lo sento, manca poco, stringo gli occhi e mi concentro cercando di sentire quel minimo piacere e venire con lui perché così tutto sembrerà meno squallido. Ci sono momenti in cui il piacere arriva, è raro, ma accade. Il corpo si risveglia, si abbandona, e per un istante mi sento viva, intera, come se questo mestiere avesse un senso ed io non fossi solo un’ombra nella notte. Ma il più delle volte quel brivido non arriva e mi sento solo un buco, un vuoto da riempire, un oggetto che esiste solo per il suo bisogno. Non c’è calore, non c’è scambio, solo un silenzio che mi inghiotte. In quei momenti, la mia mente vaga, si aggrappa a pensieri lontani, cercando di non ascoltare. E quando tutto finisce, resto lì, con un senso di incompletezza che mi pesa sul petto, come se una parte di me fosse stata rubata, lasciandomi ancora più vuota di prima. Mi sistemo il vestito, lui si allontana senza voltarsi, e il silenzio torna a reclamare il vicolo. Resto lì, con il cuore che batte troppo forte, il rossetto ormai cancellato, e la consapevolezza che questo momento, per quanto disperato, è stato un grido contro il nulla. Un grido che nessuno sentirà, ma che, per un istante, mi ha fatta sentire meno sola. Mi guardo intorno e non provo vergogna per quello che ho fatto, per quello che farò di nuovo a breve. Tutte le mie amiche del resto sono nel giro, in un modo o nell’altro. C’è chi fa massaggi, chi gira video porno che finiscono sulle bancarelle a borsa nera. Alcune scrivono il loro numero sui volantini dei ristoranti, altre si vendono per una cena abbondante. È il “survival sex”, il sesso per sopravvivenza. Qui non c’è scelta. Mia cugina pensava di trovarla. È scappata in Italia, sognando una vita migliore. Ma da quello che so fa lo stesso mio mestiere e per giunta sfruttata da nostri connazionali. Le autorità sanno tutto, vedono tutto, ma tacciono. Le guardie locali, con le loro uniformi sporche e sgualcite e i fucili appoggiati sulle spalle, chiudono un occhio, a volte anche due. Non è compassione, né pietà. È convenienza. Ricevono la loro parte, un mazzetto di banconote infilato in una tasca lontano da occhi indiscreti. Siamo l’ultimo anello della catena, noi ragazze che camminiamo sotto i lampioni, con il trucco pesante e i tacchi che scricchiolano sulla polvere. Loro, le guardie, sono il penultimo, sempre pronti a voltarsi dall’altra parte, a patto che il prezzo sia giusto. Sopravviviamo così, in un equilibrio precario fatto di silenzi comprati e segreti condivisi. Ma sopra di noi ci sono gli intoccabili, i tenutari dei bordelli, i veri padroni della notte. Sono ricchi, potenti, con le tasche gonfie di soldi e le conoscenze giuste per restare al sicuro. Gestiscono i quartieri hard, quelle strade nascoste dove la luce al neon tinge tutto di bianco e pulito. Di notte, in quei locali, le ragazze ballano senza veli, i corpi che si muovono come fiamme sotto gli occhi di uomini che pagano per sognare. Di giorno, gli stessi locali si trasformano in caffè innocui, dove si parla di politica, come se la notte non fosse mai esistita. È un gioco sadico, un’ipocrisia che si ripete ogni giorno, un mondo che si nasconde dietro tende di velluto e sorrisi falsi. Io invece preferisco stare qui e non lavorare nei bordelli, anche se sarebbe più facile. I bordelli sono fortezze di cemento, con stanze buie e tende pesanti. Lì, le ragazze sono protette, in un certo senso: c’è un tetto sopra la testa, un letto invece di un vicolo, e guardie pagate per tenere lontani i guai. Ma quella protezione ha un costo che non posso permettermi. I tenutari non ti assumono, ti possiedono. Una volta dentro, sei loro: una parte dei tuoi guadagni va nelle loro tasche, e non è solo denaro. È la tua libertà, il tuo nome, la tua dignità. Ti danno un letto, sì, ma anche un padrone. Ti dicono quando lavorare, con chi, e come. Ti controllano, ti schedano, ti incatenano con debiti che non pagherai mai. Ho visto ragazze sparire nei bordelli, entrare con un sorriso e uscirne con occhi vuoti, se mai ne escono. Alcune non tornano più a casa, vendute come merce. Battere per le strade è diverso. È duro, pericoloso, ma è mio. Scelgo io quando uscire, dove andare, chi accettare. Non devo dividere i miei soldi con nessuno, tranne le guardie che prendono la loro tangente. La strada è un rischio costante: un cliente che non paga, uno che alza le mani, il freddo della notte che ti morde la pelle. Ma è anche libertà, per quanto sporca e fragile. Posso tornare a casa dalle mie sorelle all’alba, con i soldi nascosti nella borsa, e nessuno mi chiede di inginocchiarmi davanti a un tenutario. Non sono proprietà di nessuno, anche se a volte mi sento proprietà della notte stessa, onesta nella sua brutalità. Preferisco il freddo della strada, il silenzio delle rovine, il ronzio del generatore. Almeno qui, so chi sono. E questa strada è la nostra rivendicazione contro un’esistenza che ci schiaccia, ma è anche il nostro dramma. Ho visto ragazze di tredici anni entrare in questo mondo. Ho visto donne di cinquant’anni fare massaggi e vendersi per meno di niente. Io, per ora, sono giovane. Ho ancora clienti. Ma so che non durerà per sempre. In un certo senso mi sento una benefattrice perché faccio dimenticare la guerra, la povertà, la polvere che ci soffoca tutti. Io sono lì per loro. Non giudico. Non sogno. Non penso al futuro. Qualcuno mi chiede se cambierà qualcosa, ora che le truppe straniere se ne sono andate. Scuoto la testa. Stanotte, mentre aspetto il prossimo cliente, guardo il cielo sopra Kalatà. È limpido, pieno di stelle, ma sembra lontano, come se appartenesse a un altro mondo. Qui, tra le rovine, c’è solo il mio corpo, le luci in lontananza delle case e il silenzio che nasconde tutto. |
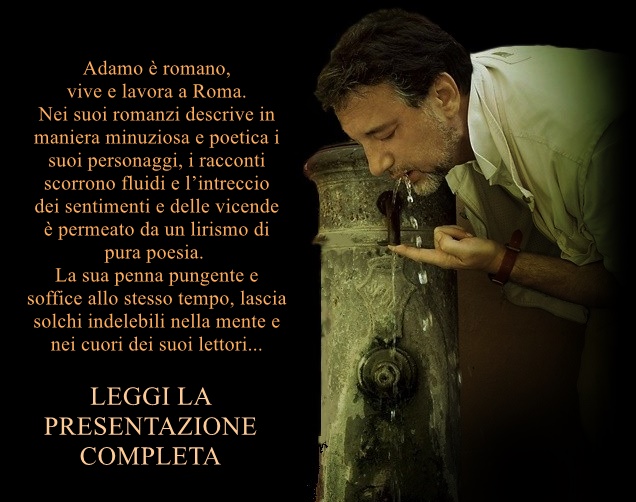
Questo racconto è opera di pura fantasia.
Nomi, personaggi e luoghi sono frutto
dell’immaginazione dell’autore e non sono da
considerarsi reali. Qualsiasi somiglianza con
fatti, scenari e persone è del tutto casuale.
IMMAGINE GENERATA DA IA
© All rights reserved Adamo Bencivenga
LEGGI GLI ALTRI RACCONTI
© Tutti i diritti riservati
Il presente racconto è tutelato dai diritti d'autore.
L'utilizzo è limitato ad un ambito esclusivamente personale.
Ne è vietata la riproduzione, in qualsiasi forma, senza il consenso dell'autore

Tutte le immagini pubblicate sono di proprietà dei rispettivi autori. Qualora l'autore ritenesse improprio l'uso, lo comunichi e l'immagine in questione verrà ritirata immediatamente. (All images and materials are copyright protected and are the property of their respective authors.and are the property of their respective authors.If the author deems improper use, they will be deleted from our site upon notification.) Scrivi a liberaeva@libero.it
COOKIE POLICY
TORNA SU (TOP)
LiberaEva Magazine Tutti i diritti Riservati Contatti
