
RACCONTO
Adamo Bencivenga
LA ZOCCOLETTA
Roma, 1957. Anna, diciassette anni, scappa dal collegio delle suore in cerca di libertà, ma trova solo le strade sporche della sopravvivenza. Soprannominata "la zoccoletta", inizia a vendere se stessa in un albergo diurno, vicino alla Stazione Termini, finché un incontro cambierà per sempre il suo destino...

|
UGiovanni cresceva nell’ingenuità dei suoi primi anni, con gli occhi spalancati sul mondo e un sorriso che sembrava rubare la luce anche alle giornate più grigie di Roma. Lo guardavo correre nel cortile interno della casa, inseguendo le ombre dei piccioni o raccogliendo sassolini che poi mi porgeva come tesori preziosi. Mi chiedevo spesso cosa vedesse in me, la sua mamma, una donna che si sentiva ancora una ragazza, segnata da un passato che non poteva raccontargli. Mi chiedevo se un giorno avrei avuto il coraggio di dirgli la verità: che suo padre era l’uomo che viveva nella stessa casa, ma che non poteva riconoscerlo; che la sua vita era iniziata in un momento di amore rubato, in una casa che non era mai stata davvero mia. Ogni volta che Giovanni mi abbracciava, con quelle manine calde e appiccicose, sentivo una stretta al cuore: era il mio tutto, ma anche il mio segreto più grande, il peso e la gioia di una scelta che avevo fatto da sola. Crescere Giovanni in quella casa era come camminare su una corda tesa sopra un precipizio. Dovevo essere madre e domestica senza mai mostrare la fatica o la paura. La mattina mi svegliavo all’alba, quando il Ghetto era ancora silenzioso, avvolto dalla nebbia che saliva dal Tevere. Preparavo la colazione per Giovanni, poi lo vestivo e lo portavo dalla portiera, la signora Teresa, che ormai era diventata una sorta di nonna adottiva con un cuore grande. Lei lo teneva con sé mentre io sbrigavo le faccende di casa. “È un angelo, il tuo Giovanni.” Mi diceva, accendendo una sigaretta con le dita ingiallite. “Non farlo crescere troppo in fretta, Anna.” Io annuivo, ma dentro di me sapevo che non avevo scelta: Giovanni sarebbe cresciuto in un mondo che non perdonava l’ingenuità, proprio come non l’aveva perdonata a me. La casa, dopo la morte di Mario, non la sentivo più mia. Laura si era insediata come padrona, con una naturalezza che mi feriva. Io, che avevo conosciuto quella casa come un rifugio, mi sentivo sempre più un’estranea, una figura che si muoveva tra le stanze senza lasciare impronte. Laura non era cattiva, ma la sua gentilezza era quella di chi dà ordini senza mai guardarti negli occhi. “Anna, il pavimento in salotto ha bisogno di cera.” Diceva, mentre sfogliava una rivista di moda, oppure “Anna, assicurati che la cena sia pronta per quando torniamo.” Io annuivo, abbassando lo sguardo, e continuavo il mio lavoro, ma ogni sua parola era un promemoria del mio posto: una domestica, non una di loro. Giovanni, ignaro di tutto, cresceva con una curiosità che mi spaventava e mi incantava. A tre anni, già parlava come un ometto. Dal canto mio gli raccontavo storie semplici, di un nonno che era andato in cielo a guardare le stelle, di una mamma che lavorava sodo per dargli una casa. Ma dentro di me tremavo al pensiero del giorno in cui avrebbe chiesto di suo padre. Cosa gli avrei detto? Che era un uomo che viveva a pochi metri da lui, ma che apparteneva a un’altra vita? Che io, sua madre, ero stata solo un’ombra nel suo passato? Per ora, lo proteggevo con il mio amore, con le canzoni che gli cantavo la sera, con le storie che inventavo per farlo addormentare. Ma sapevo che non sarebbe bastato per sempre e soprattutto non sarebbe stato facile. Lui era un figlio senza nome e senza padre e sin da quando era nato sapevo che la sua vita non sarebbe stata rose e fiori. Lui come volto familiare conosceva solo Clara che chiamava zia mentre con Davide e Laura aveva avuto sempre un atteggiamento distaccato come se in un certo senso, pur vedendoli ogni giorno, intuisse che non fossero di famiglia. ****** Tutto proseguì senza emozioni o sussulti finché nell’inverno del 1967 Laura, incinta di sette mesi, decise di trascorrere l’ultimo periodo di gravidanza a casa della madre. Rimanemmo in casa io, Davide e Giovanni. Per un attimo pensai davvero alla famigliola felice e che in qualche modo il buon Dio mi stesse premiando. E fu proprio in quel periodo che sorpresi Davide a guardami come ai vecchi tempi. Certo sì, erano occhiate rapide, ma il ricordo delle nostre notti mi facevano tremare le gambe. Quando eravamo in casa e in particolare quando Giovanni era da Teresa o a scuola, lo vedevo nervoso, impaziente. Così una mattina da soli, nel suo giorno di riposo settimanale, mi chiese di pranzare insieme. Venne più volte in cucina ed io intuii che stesse succedendo qualcosa. Addirittura mi aiutò ad apparecchiare la tavola e quando ci sedemmo, dopo qualche battuta, si avvicinò e sussurrando, come se temesse di essere sentito da altri, mi disse: “Le hai ancora quelle mutandine rosse?” Sentii il mondo crollarmi addosso. Impacciata abbassai lo sguardo, poi sorrisi senza rispondere e allora lui si alzò e mi strinse le spalle. Fu un attimo e subito dopo chinandosi verso di me poggiò le sue labbra sulle mie. Durante quel bacio mormorai: “Dai, Davide, non possiamo… La signora Laura…” Ma le mie parole si persero nel calore delle sue carezze. Il cuore mi batteva all’impazzata, mentre le labbra di Davide, calde e familiari, risvegliavano in me un desiderio che avevo cercato di seppellire. Dalla nascita di Giovanni erano passati quasi sette anni ed io ero vissuta in un eterno letargo. Quel bacio era un’esplosione di vita, un lampo che illuminava il grigiore della mia esistenza fatta di doveri e silenzi. Sentivo il calore delle sue mani sul mio seno, la sua stretta possente di maschio e mi sentii di nuovo donna, oltre che madre e domestica. E fu proprio in quel momento che mi abbandonai, incapace di resistere alla forza di un amore che, nonostante tutto, non aveva mai smesso di bruciare dentro di me. Travolta da un misto di euforia e terrore mi sentii una donna desiderata, viva, capace di provare ancora piacere, ma allo stesso tempo sapevo che quel momento rubato, a Giovanni, a Laura, era un filo sottile, pronto a spezzarsi sotto il peso di una vita che non mi apparteneva. Quando Davide mi sollevo ridendo e mi portò nella sua stanza, mi sentii come se stessi camminando su un confine pericoloso, tra il sogno e la rovina, tra l’incapacità di resistere e l’ineluttabilità del destino. Il letto matrimoniale, con le lenzuola che avevo impeccabilmente stirato, mi sembrava un territorio proibito, un vero e proprio sacrilegio. Cercai di non pensarci mentre mi abbandonavo a lui, ma ogni tocco, ogni respiro, lo sentivo come una promessa che sarebbe durata solo quelle poche ore. L’amore fu intenso e meraviglioso, pieno di tenerezza e passione, addirittura per qualche minuto ci addormentammo abbracciati, ma al risveglio con la luce rossastra di quel tramonto romano che filtrava attraverso le tende, mi chiesi se fosse stato vero o avessi solo sognato. Per un istante immaginai un mondo in cui quel momento non fosse un’eccezione, ma la norma. Quando Davide mi baciò di nuovo, chiedendomi il permesso con quella gentilezza che mi disarmava, sentii un’ondata di calore e gratitudine, ma anche una fitta di dolore. Sapeva che quell’amore, per quanto intenso, era destinato a rimanere clandestino e solo nei momenti rubati, ma soprattutto mi dilaniava l’anima il dubbio se confessargli che non avrebbe dovuto aspettare il parto di Laura per essere padre. Lui lo era già, anche se forse non lo avrebbe mai accettato. Ogni bacio, ogni carezza, era un’ancora che mi teneva legata a lui, ma anche una catena che mi inchiodava al ruolo di amante segreta, mai abbastanza per essere altro. Non successe solo quella volta, accadde ogni qualvolta eravamo soli in casa ed io mi preparavo per lui, indossavo le mutandine rosse sentendomi di nuovo viva nonostante quell’amore fosse un groviglio disperazione e rimpianti. Lui mi possedeva carnalmente con tutto se stesso, come se l’amore con Laura fino ad allora non fosse stato altro che un dovere. Ed io lo amavo con una devozione che rasentava l’ossessione, ma che era anche intrisa di una profonda consapevolezza della mia fragilità. Ogni volta che mi abbandonavo a lui, sentivo come se ogni incontro mi togliesse un pezzo di me, lasciandomi più vuota e più piena di lui allo stesso tempo. Era un amore che mi consumava, che mi dava una ragione per alzarmi ogni mattina e, allo stesso tempo, mi condannava a un’esistenza di silenzi priva di ogni attesa. Non potevo immaginare una vita senza Davide, eppure, in fondo al cuore, sapevo che quel sentimento, così potente e totalizzante, era anche la mia prigione, un sogno che non sarebbe mai diventato realtà. Quando Laura tornò dopo la gravidanza, mi preparai a riprendere il mio ruolo invisibile, ma lei assorbita dalla piccola Cristina, non si accorse di nulla, e Davide nei nostri momenti rubati mi cercava sempre con più passione. Sapevo che quell’amore non mi avrebbe portata da nessuna parte, ormai avevo accettato il mio ruolo come il mio grembiule logoro, come le mani screpolate. Eppure, anche in quella situazione, trovavo momenti di resistenza, come se quell’amore clandestino potesse riempire ogni mio altro desiderio e trasmettere indirettamente a Giovanni l’amore di suo padre. Ogni domenica, quando Laura e Davide uscivano per andare a messa o a pranzo dai parenti di lei e Giovanni era nella sua stanza a fare i compiti, mi sedevo in cucina con una tazza di tè e sfogliavo un libro a caso del professor Mario. Leggevo a bassa voce, come faceva lui, e per un attimo mi sentivo meno sola. A volte, uscivo per una passeggiata, con il vento che mi scompigliava i capelli, e guardavo i passanti, le coppie, i bambini che correvano. Mi chiedevo se un giorno avrei avuto una vita diversa, una casa mia, un padre per Giovanni, qualcuno che mi chiamasse per nome senza darmi ordini. Ma poi tornavo indietro, prendevo mio figlio per mano e cercavo di farmi forza pensando a quando per gli altri ero semplicemente una “zoccoletta”. Beh sì, di strada ne avevo fatta pur rimanendo ferma sempre allo stesso posto. E quando aprivo la porta di quella casa grande e piena di ricordi riprendevo il mio posto, perché, qualunque fosse stata la mia vita futura, non avrei mai potuto immaginarla senza Davide. ****** Nell’aprile del 1970 trovai un lavoro come aiutante in una sartoria vicino a Campo de’ Fiori. Non era un mestiere prestigioso, ma per me rappresentava un nuovo inizio, un passo verso qualcosa che fosse mio, lontano dal ruolo di domestica che mi aveva definito per anni. Cucire mi era sempre piaciuto: fin dai tempi del collegio, quando passavo ore a lavorare il fustagno ruvido sotto lo sguardo severo delle suore, trovavo una sorta di pace nel ritmo regolare dell’ago che entrava e usciva dal tessuto. Ogni punto era un piccolo atto di creazione, un modo per lasciare un segno, per costruire qualcosa che durasse. Ora, a trent’anni, con Giovanni che cresceva e un passato che pesava come un’ombra, quel lavoro era una possibilità di riscatto. La sartoria era un piccolo negozio incastrato tra una frutteria e un’osteria, con una vetrina polverosa e una tenda sbiadita che sbatteva contro la porta ogni volta che qualcuno entrava. La proprietaria, la signora Adele, era una donna sulla sessantina, con i capelli grigi raccolti in uno chignon e dita agili che sembravano danzare sul tessuto. Mi aveva assunto dopo aver visto come rammendavo una gonna con precisione quasi maniacale. “Hai le mani di una che sa cosa vuole. Ma qui non si fanno solo orli, ragazza. Qui si crea.” Quelle parole mi erano rimaste impresse, come un invito a immaginare un futuro diverso. Le giornate in sartoria erano lunghe, ma piene di vita. La mattina sbrigavo le faccende a casa di Davide e Laura, correndo tra i pavimenti da lucidare e i pasti da preparare, poi, nel primo pomeriggio, lasciavo Giovanni con la signora Teresa o a scuola. Poi camminavo fino a Campo de’ Fiori, con il cuore che si alleggeriva a ogni passo. L’odore di pane appena sfornato e di fiori freschi mi accoglieva in piazza, e per un momento mi sembrava di essere solo Anna, una donna con un mestiere, un nome e una possibilità. In sartoria, il mio compito era semplice all’inizio: orli, bottoni, piccole riparazioni. Ma la signora Adele mi osservava, e col tempo mi affidò lavori più complessi: rifinire una gonna di seta, ricamare un colletto, aggiustare un abito da sposa con pizzi così delicati che tremavo al pensiero di rovinarli. Ogni lira guadagnata la mettevo da parte con cura, nascosta in una scatola di latta sotto il letto. Sognavo una stanza tutta mia, nostra, un posto dove Giovanni potesse crescere senza la sensazione di essere un intruso in una casa che non gli apparteneva. In casa, ogni volta che sparecchiavo la tavola o stiravo le loro camicie, sentivo un nodo stringermi lo stomaco. Non ero più la ragazza di un tempo, ma una madre, una donna che voleva di più, per sé e per suo figlio. ****** Nel 1971, con l’aiuto di Clara, trovai finalmente il coraggio di fare il grande passo. Clara, che ormai si era stabilita in una vita più comoda grazie al suo uomo, mi accompagnò a vedere una stanzetta in affitto a Testaccio, un quartiere popolare poco fuori dal centro. La stanza era piccola, con i muri scrostati e una finestra che dava su un cortile rumoroso, pieno di bambini che giocavano e di donne che si chiamavano da un balcone all’altro. Il letto scricchiolava, la stufa funzionava a singhiozzo, e il bagno era in comune con altre due famiglie, ma quando firmai il contratto, sentii una leggerezza che non provavo da anni. Era mia, nostra. La prima notte, con Giovanni addormentato su un lettino che avevo comprato di seconda mano, mi sedetti sul pavimento, con la schiena contro il muro, e piansi. Non di tristezza, ma di sollievo. Per la prima volta, avevo un posto dove essere Anna, la madre di Giovanni, non l’ombra di qualcun altro. Portare Giovanni in quella stanza fu come regalargli un pezzo di mondo. A dodici anni, era un ragazzo sveglio, con gli occhi curiosi di Davide e una parlantina da ometto. Gli piaceva correre nel cortile, giocare a pallone con i figli dei vicini, tornare a casa con le ginocchia sbucciate e un sorriso che mi scaldava il cuore. Ma era anche sensibile, e a volte lo sorprendevo a guardarmi con un’espressione seria, come se cercasse di capire i miei silenzi. “Mamma, perché non abbiamo un papà come gli altri?” Mi chiese una volta, mentre eravamo a cena. Non seppi cosa rispondere. Gli accarezzai i capelli, gli dissi che eravamo una squadra, io e lui, e che questo bastava. Ma dentro di me sapevo che un giorno o l’altro avrei dovuto svelargli chi fosse suo padre. Continuavo a lavorare in sartoria, imparando il mestiere con una dedizione che sorprendeva persino me stessa. La signora Adele mi insegnò a tagliare i modelli, a scegliere i tessuti, a capire come un abito poteva trasformare una donna, farla sentire più sicura, più bella. “Anna, hai un dono.” Mi diceva. “Non è solo cucire, è capire le persone.” Quelle parole mi davano una forza nuova. Iniziai a fare piccoli lavori di cucito per conto mio, per le vicine, per le amiche di Clara, per qualche cliente che aveva sentito parlare di me. Ogni punto, ogni orlo, era un mattone verso un futuro che volevo costruire per Giovanni. Sognavo di aprire una piccola sartoria tutta mia, un giorno, un posto con una vetrina pulita e il mio nome scritto sopra. Nel frattempo, continuavo ad andare a casa di Davide e Laura tre volte a settimana. Lavorare per loro era diventato più difficile, non per le faccende, ma per il peso emotivo. Laura, ora madre di due figli – Cristina e la piccola Sandra, era sempre più assorbita dalla sua vita di moglie e madre. Organizzava cene eleganti, invitava colleghi di Davide, rideva con loro in salotto mentre io servivo il vino o sparecchiavo i piatti. Mi trattava con una cortesia che bruciava più di un insulto, come se fossi un pezzo di arredamento, utile ma invisibile. Davide, invece, era un enigma. Insegnava in un liceo prestigioso, era rispettato, ammirato, ma quando i nostri sguardi si incrociavano, c’era sempre un’ombra, un misto di rimpianto e distanza. Non parlavamo mai di noi, di quello che era stato, ma a volte, quando Laura era fuori con le bambine, capitava ancora. Succedeva nei momenti più inaspettati: una mattina, mentre stiravo una delle sue camicie, mi si avvicinò e mi sfiorò la mano. “Anna.” Sussurrò, con quella voce che mi faceva ancora tremare. Non disse altro, ma mi attirò a sé, e io, come sempre, non seppi resistere. Facemmo l’amore nella stanza degli ospiti, in fretta, con il cuore che batteva all’impazzata per la paura che qualcuno potesse entrare. Ogni volta era come rivivere quella sera sul divano, con la radio che mandava musica americana, ma ora c’era un’amarezza nuova, un senso di precarietà. Eppure, ogni volta che mi stringeva, mi illudevo che ci fosse ancora qualcosa di noi, un frammento di quella passione che ci aveva uniti anni prima. Quelle ricadute, però, mi lasciavano più vuota che mai. Tornavo a casa, nella mia stanzetta a Testaccio, e mi guardavo allo specchio, chiedendomi chi fossi davvero. Ero ancora la ragazza che sognava un futuro con Davide? O ero solo la madre di Giovanni, la sarta, la donna che si aggrappava a un amore impossibile? Clara, che mi conosceva meglio di chiunque altro, lo vedeva nei miei occhi. “Anna, devi smetterla con lui.” Mi disse una sera, mentre bevevamo un caffè in un bar vicino a Piazza Navona. “Davide non ti darà mai quello che vuoi. Meriti di più, per te e per Giovanni.” Aveva ragione, ma il mio cuore non ascoltava. Davide era ancora il centro del mio mondo, il metro con cui misuravo ogni cosa, anche se ogni incontro mi spezzava un po’ di più. ****** Fu in quel periodo, nell’autunno del 1972, che incontrai Giuseppe. Ero con Clara in una sala da tè vicino a Piazza di Spagna, un posto elegante con tovaglie bianche e tazzine di porcellana che mi facevano sentire fuori posto. Clara, con il suo solito spirito, stava raccontando qualcosa che le era capitata giorni prima, quando un uomo si avvicinò al nostro tavolo. Lui si rivolse a me e Clara, come al solito sveglia, con un pretesto, si alzò e mi lasciò sola, dandomi una strizzatina d’occhio. Lui si presentò come Giuseppe, un ferroviere di quarantacinque anni, con i capelli brizzolati e un sorriso gentile. Disse che mi aveva notata da lontano, che gli piaceva il mio modo di ridere, e mi chiese se poteva sedersi. Annuii, più per cortesia che per interesse. Parlava con calma, raccontandomi del suo lavoro, della sua vita semplice, della casa che aveva comprato a Ostia con i risparmi di anni. “Sto cercando una ragazza per sistemarmi.” Disse, guardandomi negli occhi. “Qualcuno con cui costruire qualcosa di serio.” Io sorrisi, ma sentii una stretta al cuore. Prima che potesse farsi illusioni, gli dissi la verità: “Ho trentadue anni, non sono sposata, ma ho un figlio di tredici anni.” Mi aspettavo che si alzasse e se ne andasse, come aveva fatto Marco anni prima quando si era accorto che non ero vergine. Invece, Giuseppe annuì, come se la notizia non lo sorprendesse. “Sono i casi della vita…” Disse. “Mi piacerebbe rivederti, se ti va. Magari sabato prossimo, qui?” Accettai, più per curiosità che per altro, e quando Clara tornò, mi prese in giro per tutto il tragitto verso casa. “Anna, il tuo fascino lo ha trafitto! Non fartelo scappare…” Poi seria: “Questo è un uomo che vuole una famiglia, non un’avventura. Pensaci, per Giovanni.” Giuseppe mi corteggiò con una costanza che mi spiazzò. Mi portava a cena in trattorie semplici, mi regalava piccoli mazzi di fiori comprati al mercato, mi ascoltava quando parlavo di Giovanni o del mio lavoro in sartoria. Gli raccontati tutto di me, tranne il periodo dell’Albergo Diurno. Lui era gentile, stabile, tutto ciò che Davide non sarebbe mai stato. Eppure, nel mio cuore, non c’era spazio per lui. Ogni volta che Giuseppe mi prendeva la mano o mi sorrideva, pensavo a Davide, al suo sguardo, ai suoi tocchi, a quell’amore che mi consumava e mi teneva prigioniera. Clara, però, insisteva: “Anna, devi pensare a Giovanni. Giuseppe è un uomo perbene, ti può dare una casa, una sicurezza. Non puoi restare legata a un sogno che non esiste.” Aveva ragione, ma accettare quella verità era come strapparmi un pezzo di anima. Sei mesi dopo, nell’aprile del 1973, accettai la proposta di matrimonio di Giuseppe. Non lo amavo, ma lo rispettavo. Era un uomo buono, che trattava Giovanni con affetto, che non chiedeva nulla del mio passato e mi offriva una stabilità che non avevo mai conosciuto. Il matrimonio fu semplice, in una piccola chiesa a Testaccio, con pochi invitati: Clara, alcune colleghe della sartoria, i fratelli di Giuseppe e naturalmente Giovanni vestito con un abito scuro cucito dalle mie mani. Dopo il matrimonio, ci trasferimmo nella casa di Giuseppe a Ostia. Era una villetta modesta, con un piccolo giardino dove Giovanni poteva giocare e una cucina che odorava di vernice fresca. Giuseppe era un marito attento, ma distante; mi trattava con rispetto, ma non c’era passione tra noi, solo una quieta convivenza. Io continuavo a lavorare in sartoria, a studiare per il diploma di sarta, a crescere Giovanni con tutto l’amore che avevo. Ma, quando tornavo a casa di Davide per le mie giornate di lavoro, sentivo il cuore battere più forte. Davide era sempre lì, con i suoi occhi che mi cercavano nei momenti di silenzio, e a volte, quando Laura non c’era, capitava ancora. L’approccio era sempre lo stesso, come una parola d’ordine, mi chiedeva: “Le porti le mutandine rosse?” Ed io fiera di quel desiderio le prendevo dalla borsa e le indossavo davanti a lui. Quei momenti erano come un fuoco che si riaccendeva ed io mi abbandonavo per vivere quel momento e sentire tutto quell’amore che Davide poteva offrirmi, nella consapevolezza che non sarebbe stato più eterno. ****** Nel 1974, ottenni il diploma da sarta. Fu un momento di orgoglio, un traguardo che dedicai a Giovanni e a me stessa. Continuai a lavorare, a risparmiare, a costruire una vita che fosse mia e a sognare di mettermi in proprio. Giovanni crebbe, diventando un ragazzo forte, intelligente, con sogni più grandi dei miei. Non gli parlai mai di Davide, né del mio passato. Clara, l’unica a conoscere tutta la verità, mi spronava a lasciarmi il passato alle spalle: “Anna, hai fatto tanto. Sei una madre, una donna, una sarta. Non sei più quella ragazza di Termini.” Aveva ragione, ma ogni volta che passavo davanti alla Stazione Termini, sentivo un brivido. Non era più paura, ma memoria: il ricordo di quanto lontano fossi arrivata, di quante battaglie avevo combattuto. Eppure, anche nella mia nuova vita, il pensiero di Davide non mi lasciava mai. Era il padre di mio figlio, l’uomo che avevo amato con tutta me stessa, e anche se ora avevo Giuseppe, una casa, un lavoro, una parte di me sarebbe sempre stata legata a lui. Ogni sera, quando tornavo a casa stanca guardavo mio figlio e vedevo in lui il futuro che avevo costruito con le mie mani, un passo alla volta, proprio come avevo giurato a me stessa in quella notte di disperazione tra le rovine delle Terme di Diocleziano. In un certo senso ringraziai quei due delinquenti, senza di loro forse non avrei avuto la forza di cambiare la mia vita. E ora non ero più la “zoccoletta”, né la ragazza senza nome del collegio, né la ragazza rifiutata da Marco perché non ero vergine! Ero io, Anna, madre, sarta, donna. E quel nome, che avevo conquistato con fatica, era il mio orgoglio più grande. |
FINE
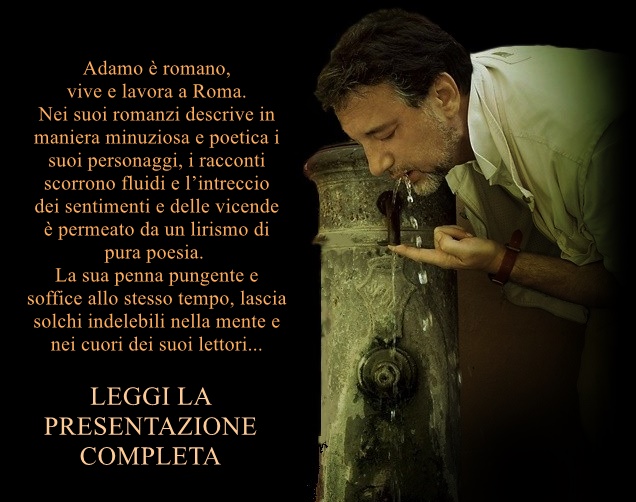
Questo racconto è opera di pura fantasia.
Nomi, personaggi e luoghi sono frutto
dell’immaginazione dell’autore e non sono da
considerarsi reali. Qualsiasi somiglianza con
fatti, scenari e persone è del tutto casuale.
IMMAGINE GENERATA DA IA
© All rights reserved Adamo Bencivenga
LEGGI GLI ALTRI RACCONTI
© Tutti i diritti riservati
Il presente racconto è tutelato dai diritti d'autore.
L'utilizzo è limitato ad un ambito esclusivamente personale.
Ne è vietata la riproduzione, in qualsiasi forma, senza il consenso dell'autore

Tutte le immagini pubblicate sono di proprietà dei rispettivi autori. Qualora l'autore ritenesse improprio l'uso, lo comunichi e l'immagine in questione verrà ritirata immediatamente. (All images and materials are copyright protected and are the property of their respective authors.and are the property of their respective authors.If the author deems improper use, they will be deleted from our site upon notification.) Scrivi a liberaeva@libero.it
COOKIE POLICY
TORNA SU (TOP)
LiberaEva Magazine Tutti i diritti Riservati Contatti
